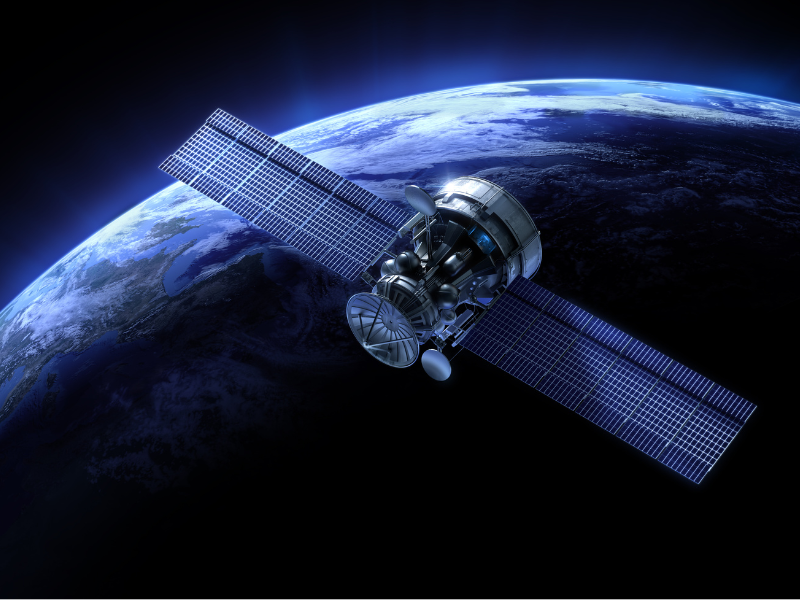Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, del 4 novembre 2025 n. 8542, il giudice amministrativo ha chiarito quali sono i presupposti applicativi che qualificano un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia, in difetto dei quali si ricade nel regime della nuova costruzione e, quindi, del permesso di costruire.
La questione nodale dell’intera vicenda ruota intorno alla nozione di ristrutturazione ricostruttiva e al tema della continuità tra il nuovo edificio e quello precedente.
1. Il giudizio di primo grado
La vicenda origina da un intervento di demolizione e ricostruzione di due edifici e contestuale cambio di destinazione d’uso da industriale a residenziale, mediante SCIA alternativa al permesso di costruire.
Il Tar Milano, con sentenza del 7 agosto 2024 n. 2353, sez. II ha accolto il ricorso presentato da alcuni condomini e dal Condominio confinante annullando il provvedimento con il quale il Comune aveva confermato la legittimità dell’intervento.
Secondo il Tar “si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente”.
Più nello specifico il Tar si pronuncia in relazione a un intervento consistente nella demolizione di un vecchio fabbricato adibito a laboratorio-deposito e nella realizzazione in suo luogo di una palazzina residenziale avente due piani fuori terra ed un piano seminterrato.
Ciò porta il giudice a ritenere che il nuovo edificio, sia per le sue caratteristiche strutturali che per la funzione cui è adibito, la quale introduce un rinnovato carico urbanistico del tutto diverso da quello prodotto dal precedente edificio, non possa che essere considerato alla stregua di una nuova costruzione.
2. Evoluzione della nozione di ristrutturazione edilizia e il difficile confine tra ristrutturazione e nuova costruzione
Como noto, la nozione di ristrutturazione edilizia, prevista dall’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 (“Testo Unico dell’Edilizia”) è stata più volte modificata dal legislatore (si veda per quanto qui rileva il DL n. 76/2000, convertito in legge n. 120 del 2020), nel segno di suo un progressivo ampliamento, e allontanamento dall’obbligo originario della fedele ricostruzione, mediante eliminazione dei vari vincoli in relazione al rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
La sostituzione della logica della “fedele ricostruzione” con un approccio più flessibile, svincolato da rigidi obblighi di forma, ha reso più incerto il confine tra la “ristrutturazione ricostruttiva” e quella la “nuova costruzione”, rendendo sempre più urgente l’individuazione di una chiara linea di demarcazione tra le due nozioni.
Si consideri, infatti, che dalla qualificazione dell’intervento alla stregua dell’una o dell’altra categoria dipende l’individuazione del titolo edilizio necessario per l’esecuzione delle opere (SCIA o permesso di costruire), con inevitabili conseguenze in tema di volumetria utilizzabile e rispetto delle distanze.
Come noto, il confine tra demo-ricostruzione e nuova costruzione è stato oggetto di ondivaghe prese di posizione tra Cassazione Penale, TAR e Consiglio di Stato che hanno portato a risultati non sempre univoci e a volte poco aderenti al dettato normativo.
Da una parte troviamo la posizione della Cassazione Penale, secondo cui costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata la traccia dovendo l’immobile presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesiste (Cass. penale, sez. III, n. 18044 dell’8 maggio 2024).
Orientamento questo, fatto proprio non solo dalla sentenza del TAR Milano riformata dal Consiglio di Stato, ma anche dal Comune di Milano nelle numerose circolari e determine che sono state emanate all’indomani dell’avvio delle indagini della Procura di Milano.
Dall’altra, un orientamento del giudice amministrativo decisamente più aperto e più aderente al dettato normativo, secondo cui il criterio distintivo tra le due tipologie di intervento (nuova costruzione o ristrutturazione costruttiva) non è più la rigida continuità con l’edificio preesistente, ma la preesistenza di un manufatto nel caso della ristrutturazione. La nuova costruzione è dunque una categoria residuale che comprende gli interventi non riconducibili in altre casistiche, che può avvenire in modo autonomo senza preesistenze da demolire. (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sentenza n. 422 del 3 giugno 2025).
3. La decisione del Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato ripercorre le modifiche normative susseguitesi nel tempo e l’evolversi della giurisprudenza sia penale che amministrativa, e prende una posizione netta sul tema della continuità affermando che detto requisito “se preteso in termini assoluti, non trova fondamento nell’attuale testo dell’articolo 3 del Testo Unico Edilizia”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada – in ciò discostandosi dalla pronuncia di prime cure del TAR Milano e dalla posizione della Cassazione penale, non è più necessario uno stretto rapporto di continuità tra l’edificio preesistente e il nuovo edificato.
Tuttavia, osserva il Consiglio di Stato, una esegesi rispettosa della norma non può nemmeno condurre a ritenere che dalla demolizione derivi una sorta di credito volumetrico “che il proprietario può spendere rimanendo comunque nell’alveo della ristrutturazione edilizia”.
Per questo motivo, il giudice amministrativo, chiarisce che in base al principio di legalità di cui all’art. 97 Cost. e alla luce del testo vigente dell’art. 3 del TU edilizia rientra nella nozione di demo-ricostruzione quell’intervento che rispetti i seguenti presupposti:
- in primo luogo, l’intervento deve avere a oggetto un unico edificio, nel senso che nella fase di ricostruzione è precluso – e, quindi, esorbita dall’ambito della ristrutturazione edilizia, per ricadere nella nuova costruzione – l’accorpamento di due o più volumi in un unico edificio, ovvero il frazionamento di un unico volume originario in più edifici di nuova realizzazione; a supporto di tale affermazione, il giudice amministrativo valorizza il tenore letterale dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia, il quale fa riferimento, al singolare, a un unico edificio preesistente da porre a confronto con un unico edificio successivo, risultante dalla demolizione e ricostruzione;
- in secondo luogo, la definizione di ristrutturazione edilizia ricostruttiva presuppone necessariamente la contestualità temporale tra la demolizione e ricostruzione, come fasi costruttive di un unico intervento, oggetto quindi di un’unica segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
- in terzo luogo, secondo l’art. 3, comma 1, lettera d) citato, il volume dell’edificio ricostruito non può superare quello del fabbricato demolito, in quanto gli incrementi di volumetria sono ammissibili “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali”; secondo il giudice amministrativo, al di là di tali ipotesi eccezionali, laddove vi sia volumetria aggiuntiva si ricade nella nuova costruzione e, quindi, devono essere qualificate come tale “tutte quelle opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito. Infatti, nelle varie evoluzioni della nozione di ‘ristrutturazione ricostruttiva’ che si sono susseguite, è rinvenibile un minimo comune denominatore, consistente nel fatto che l’intervento deve comunque risultare ‘neutro’ sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica”.
Il superamento anche solo di uno di questi parametri, pertanto, secondo i giudici, rende la demolizione e ricostruzione di un edificio qualificabile come nuova costruzione, soggetta al regime previsto per il permesso di costruire.
In definitiva, con la sentenza in commento viene ridefinito il concetto di “continuità” tra vecchio e nuovo, non più inteso come vincolo di forma o fisico ma nel senso più ampio e dinamico di neutralità. Ciò che rileva è, l’unicità dell’edificio, la contestualità temporale tra demolizione e ricostruzione e il rispetto della volumetria originaria senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio.
*
La sentenza del Consiglio di Stato ha sicuramente il pregio di individuare in modo chiaro i presupposti applicativi della cd “ristrutturazione ricostruttiva”, tema al centro di un acceso dibattito, giuridico e politico, di particolare interesse per tutti gli operatori del settore edilizio.
La pronuncia chiarisce con efficacia alcuni principi:
- non è più richiesta la corrispondenza fisica con il manufatto preesistente, potendo variare forma, prospetti, sagoma e sedime;
- il limite volumetrico continua a rappresentare il criterio discriminante tra ristrutturazione edilizia e nuova edificazione;
- l’intervento di ristrutturazione si conferma quale operazione neutra, suscettibile di esiti progettuali anche significativamente differenti, purché armonizzati con le caratteristiche del lotto e del contesto urbanistico circostante;
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in relazione a un complesso non vincolato. Nei casi di immobili soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, permane, invece, l’obbligo di mantenere coerenza in termini di sagoma, materiali, prospetti e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, a salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali riconosciuti.
In conclusione, la decisione in commento offre certezze interpretative alle amministrazioni e agli operatori e riporta la nozione di ristrutturazione edilizia entro i binari della legge in ossequio al principio di legalità, superando così vincoli formali ormai desueti che ne ostacolano l’evoluzione, come l’obbligo di dovere conservare la traccia e le caratteristiche funzionali o identitarie dell’edificio originario.
DOWNLOAD PDF